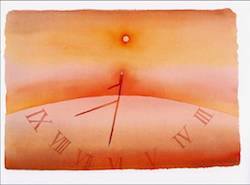Se provassimo a fare un sondaggio e chiedessimo a un campione di italiani cosa intende col termine famiglia verosimilmente avremmo risposte convergenti su due caratteristiche. La prima è il matrimonio come fondamento, la seconda è il modello nucleare come configurazione, cioè genitori con uno o più figli. Ora però proviamo a confrontare questa idea di famiglia con i dati empirici disponibili e verifichiamo cosa accade (1). In Italia, le coppie con figli sono soltanto il 36 per cento, cioè poco più di una su tre, e dal ’98 sono diminuite del 10 per cento. Cioè, l’idea di famiglia che emergerebbe da un eventuale sondaggio è oggi, nella società italiana, largamente minoritaria.
Le nuove forme familiari (convivenze, single non vedovi, monogenitori ecc.) raggiungono il 28 per cento, con un incremento dal ’98 del 12 per cento: rappresentano il 20 per cento della popolazione, ossia 12 milioni di persone. All’interno delle nuove forme di vita familiare le convivenze sono in crescita: 6 milioni di persone le hanno sperimentate nel corso della loro vita. Una coppia su tre ha convissuto prima di sposarsi e un bambino su quattro nasce in convivenze. I matrimoni sono in netta diminuzione, dal 2008 al 2011 hanno subìto un calo del 17 per cento. Il 40 per cento dei quali si celebra con rito civile, anche se nelle regioni del nord sono già al 52 per cento. Le separazioni, invece, sono in crescita esponenziale: dal ’95 al 2011 sono cresciute del 68 per cento e i divorzi sono raddoppiati. La durata media dei matrimoni è di 15 anni e l’età dei coniugi alla separazione è, in media, 46 anni per gli uomini e 43 per le donne.
Tre fenomeni contribuiscono a configurare gli attuali modelli familiari: Una consistente denatalità, che disegna una forma di famiglia snella, per cui, per esempio, è possibile per quattro nonni avere solo un nipote. Un andamento delle nascite, quindi, ben lontano dal colmare il tasso di rimpiazzo intergenerazionale.
L’allungamento della vita media, con una presenza più numerosa di anziani, che allunga la composizione del nucleo familiare. L’uscita ritardata dei giovani dal nucleo familiare d’origine per ragioni legate alla difficoltà di trovare un’occupazione o di disporre di un reddito autonomo. Tali condizioni mutano la forma dei rapporti tra i componenti del nucleo familiare.
In effetti, più generazioni si trovano a vivere contemporaneamente per lunghi periodi di tempo.
“Oggi si può essere simultaneamente nonna, madre e anche figlia” (2). Dunque il modello di famiglia nucleare fondato sul matrimonio, diffuso nell’immaginario collettivo, è in forte declino.
E’ allora più corretto riferirsi a forme di vita familiari plurali. Per poter chiarire la mia ipotesi e provare a spiegare le ragioni che hanno provocato così velocemente il declino del modello familiare nucleare, consolidatosi nel nostro Paese appena sessant’anni fa (ricordiamo che questo modello si è diffuso soprattutto in funzione del consolidamento della società industriale), occorre correlare i dati che ho esposto con due questioni fondamentali.
La prima è l’aumento delle disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza. Indagini recenti (3) rilevano un aumento preoccupante del numero di famiglie in stato di povertà.
Nel 2012 sono il 16 per cento e coinvolgono circa 8 milioni di persone.
Nell’ultimo anno, un quarto (il 25 per cento) della popolazione residente in Italia ha sofferto qualche disagio economico.
Oltre che tra le famiglie di operai e di lavoratori in proprio, la povertà aumenta tra gli impiegati e persino tra i dirigenti e tra le famiglie dove i redditi da lavoro si associano a redditi da pensione. E la povertà non è solo una faccenda economica, ma incide sulle possibilità di costruire un’immagine dignitosa della propria persona e provoca difficoltà ai legami e alle relazioni all’interno e all’esterno del nucleo familiare.
Aumenta la povertà, ma l’altra faccia della medaglia mostra una scandalosa concentrazione della ricchezza: il 10 per cento delle famiglie possiede il 50 per cento della ricchezza totale.
La seconda questione riguarda la mobilità ascendente (4), ossia si è rotto l’ascensore sociale. Per mobilità s’intende l’insieme dei cambiamenti di classe sociale dei figli rispetto ai genitori nel passaggio da una generazione all’altra (intergenerazionale) oppure ai cambiamenti che avvengono nel corso della vita di un individuo (intragenerazionale).
Il passaggio dalla posizione di origine sociale alla nuova destinazione non è neutro.
La classe sociale di origine influisce in misura rilevante sulla mobilità sociale, determinando rilevanti diseguaglianze nelle opportunità degli individui.
Studi sociologici rilevano che le opportunità di ascesa a classi sociali superiori sono fortemente diseguali in ragione della posizione di partenza ereditata dai padri.
Negli anni ’60 e ’70 le opportunità di mobilità ascendente di cui hanno goduto i figli delle classi più svantaggiate erano in un certo senso inevitabili: se a crescere, più che in passato, era il numero di posizioni sociali più elevate, non si poteva fare altro che abbandonare la classe di origine e salire.
Le opportunità di mobilità sociale sono distribuite in modo diseguale nella popolazione e dipendono in misura significativa dalla classe d’origine. Essere figlio di un medico o di un operaio non è affatto la stessa cosa: le probabilità di diventare libero professionista, imprenditore o dirigente sono, nel primo caso, molto più elevate che nel secondo.
I figli della borghesia sono in netto vantaggio anche nella competizione per l’accesso a lavori impiegatizi.
E’ evidente che le disuguaglianze di classe continuano a trasmettersi di padre in figlio. Intanto, il welfare statale è entrato in crisi e cresce, conseguentemente, l’investimento diretto delle famiglie finalizzato a integrare l’offerta pubblica nella sanità, nell’assistenza, nella formazione e in previdenza.
I lavori, all’insegna della flessibilità si fanno atipici, precari, sommersi, a bassa remunerazione e diventano sempre più privi di tutela.
Alla famiglia viene attribuito, quindi, il ruolo di rete di protezione. E’ una famiglia “tutor” come la definisce il Censis. Il risparmio accumulato in precedenza e la possibilità di disporre di una casa di proprietà permettono ancora (ma fino a quando?) a una quota di famiglie, in prevalenza del ceto medio, di sostituirsi ai servizi pubblici ormai inesistenti.
Intorno alla metà degli anni Cinquanta del secolo scorso un sociologo americano, E. Banfield (5), approdò in un paesino della Basilicata per realizzare una ricerca che spiegasse l’incapacità delle famiglie meridionali ad agire per il bene comune. Coniò un’espressione che è rimasta nel lessico non solo scientifico, ma anche giornalistico: “familismo amorale”. Consisterebbe nel massimizzare i vantaggi materiali e immediati del proprio ristretto nucleo familiare e di supporre che tutti gli altri facciano altrettanto.
Ebbene proviamo a verificare, dopo sessant’anni, cos’è rimasto del familismo amorale di Banfield. Poco o nulla nella maggior parte delle famiglie, meridionali o meno. Ma in alcuni modelli familiari particolari, invece, il familismo amorale sembra ancora un ethos persistente. Fatte le ovvie differenze, si tratta delle famiglie della delinquenza organizzata, con forti legami di consanguineità e assoluta fedeltà al proprio clan familiare e di alcune famiglie dell’alta borghesia (parte di queste ultime le ritroviamo in quel 10 per cento che detiene la metà della ricchezza totale) presenti nell’industria, nella finanza, nelle università e in alcune professioni. Esse dispongono di dispositivi che fanno da barriera all’entrata nei rispettivi contesti, “proteggendo” così il proprio gruppo familiare. Infine, una riflessione sul modello culturale prevalente nella società in generale e, conseguentemente, in molte famiglie.
Una cultura consumistica che “predilige prodotti pronti per l’uso, soluzioni rapide, soddisfazione immediata, risultati senza troppa fatica, ricette infallibili, assicurazione contro tutti i rischi e così via” (6).
Anche l’esperienza di una relazione affettiva sempre più spesso diviene simile al consumo di merci, che attira, seduce, promettendo soddisfazioni immediate e risultati senza sforzi. Il nostro è tempo di legami deboli. Se investi in una relazione occorre non impegnarsi a lungo termine.
L’organizzazione familiare, qualunque sia il suo modello, rappresenta un equilibrio che si costituisce come risposta a bisogni interni – accudimento, riproduzione, sostegno – ma anche a circostanze esterne – situazione economica, demografica, di lavoro.
E’ dunque ovvio che la famiglia non è un semplice terminale passivo del mutamento sociale.
Tuttavia, gli attuali assetti economici – mercato del lavoro, blocco della mobilità sociale ascendente, finanziarizzazione dell’economia, da un lato e i modelli culturali che escludono impegni a lungo termine e assunzione di responsabilità nei rapporti sostituti da relazioni personali il cui tasso di soddisfazione somiglia sempre più all’indice della borsa valori, dall’altro provocano in larga misura mutamenti nelle forme di vita familiare.
Pertanto la mia ipotesi è che le famiglie sono condizionate, in larga misura, dai modelli economici e culturali prevalenti.
O meglio, le forme che assumono ne sono una rielaborata risposta.
E purtroppo, una visione, sin troppo benevola, che vorrebbe ascrivere a una improbabile emancipazione dei costumi e a una maggiore libertà individuale gli attuali modelli familiari deboli, sembra davvero non cogliere nel segno.
Del resto basterebbe verificare cosa accade, anche nelle grandi organizzazioni, quando una dipendente è in gravidanza o richiede il part time, per misurare, per esempio, il rispetto della femminilità o le possibilità di carriera.
Oppure se provassimo a pensare a due giovani con lavoro incerto e precario che volessero intraprendere una relazione a lungo termine, quante possibilità concrete essi avrebbero di realizzare i loro intenti.
Un’ultima considerazione vorrei indirizzarla ai policy maker. Le politiche per la famiglia sono soprattutto politiche per la società: una più equa distribuzione della ricchezza; una maggiore mobilità sociale; un mercato del lavoro con possibilità concrete, più tutelate, meno precarie e discontinue di occupazione; una formazione dei giovani orientata all’assunzione di responsabilità e al pensiero critico; una ristrutturazione dei tempi di lavoro e di quelli dedicati alle cure domestiche.
Ma per andare verso questa direzione la politica dovrebbe smettere di essere solo un aggettivo di economia.
Sergio D’Angelo – riproduzione riservata
Note e bibliografia
*Il presente articolo è una rielaborazione dell’intervento presentato dall’autore al convegno “Conversazioni sulla famiglia” svoltosi a Barletta l’11 aprile 2014.
Note:
(1) Fonte: rielaborazione dati Istat.
(2) Chiara Saraceno, Coppie e famiglie, Feltrinelli.
(3) Fonte: rielaborazione dati Bankit.
(4) Fonte: rielaborazione dati Istat.
(5) Edward C. Banfield, Le basi morali di una società arretrata, Il Mulino.
(6) Zygmunt Bauman, Amore liquido, Laterza.